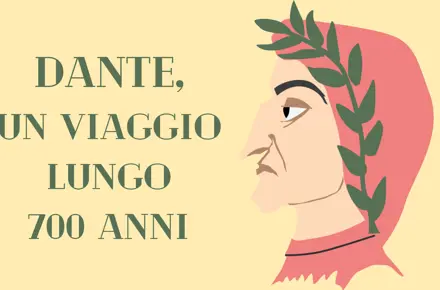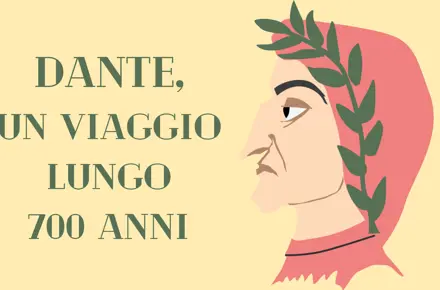
Approfondisci il fantastico
Quando l’unico limite a ciò che vogliamo raccontare è la nostra fantasia, ci troviamo nella dimensione libera e imprevedibile della letteratura fantastica.
Che cos’è il fantastico?
Il fantastico è un genere letterario caratterizzato dal ricorso a elementi – creature, ambientazioni, avvenimenti – che non sono riconducibili all’esperienza della realtà, cioè che non sono verosimili. Questo non esclude la presenza di elementi del reale, anzi: spesso l’efficacia del fantastico si basa proprio sul fatto che avvenimenti inspiegabili si verifichino all’interno di un contesto ordinario e verosimile. Lo scarto dalla realtà – lo strano, l’inaspettato, il meraviglioso, l’inquietante – sarà avvertito con maggior forza proprio perché si staglia su uno sfondo di normalità.
Come definire il fantastico?
Jorge Luis Borges (1899-1986), autore argentino tra i più noti esponenti del genere fantastico contemporaneo, si chiedeva: «L’Universo, la nostra vita, appartiene al genere reale o al genere fantastico?». Una domanda simile, a maggior ragione, è legittima quando si parla di letteratura: ogni testo che non sia di cronaca, infatti, contiene elementi che sono il frutto della fantasia di chi lo scrive.
Se si parla di generi letterari, tuttavia, il concetto di fantastico viene utilizzato in modo più specifico come uno strumento di classificazione dei testi. Il critico canadese Northrop Frye (1912-1991), cercando di classificare i mondi della finzione nel loro insieme, propone la verosimiglianza come una categoria fondamentale di distinzione, ed afferma che i due poli essenziali della letteratura sono costituiti dal racconto verosimile e dal racconto in cui i personaggi “possono fare qualunque cosa”, anche a dispetto di qualsiasi verosimiglianza. In primo luogo è dunque necessario delineare una prima grande distinzione tra realistico e fantastico: in questo senso rientrano nel fantastico tutti i generi letterari non realistici come il fantasy, la fantascienza e l’horror.
In seconda battuta possiamo invece parlare di fantastico come di un genere letterario vero e proprio, all’interno del quale troviamo spesso la presenza dell’elemento macabro e angoscioso che non può che suscitare perplessità a fronte dell’incredibilità dei fatti.
Il teorico della letteratura bulgaro Tzvetan Todorov (1939-2017) sostiene in primo luogo che il fantastico debba essere caratterizzato dall’incertezza: i fatti incredibili che vengono raccontati devono essere inspiegabili, e in chi legge deve rimanere il dubbio circa la loro natura.
In un mondo che è sicuramente il nostro, quello che conosciamo, senza diavoli, né silfidi, né vampiri, si verifica un avvenimento che non si può spiegare con le leggi del mondo che ci è familiare. Colui che percepisce l’avvenimento deve optare per una delle due soluzioni possibili: o si tratta di un’illusione dei sensi, e in tal caso le leggi rimangono quelle che sono, oppure l’avvenimento è realmente accaduto, ma allora questa realtà è governata da leggi a noi ignote. […] Il fantastico occupa il lasso di tempo di questa incertezza.
(T. Todorov, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano 1977)
Quando l’incertezza finisce, secondo il critico, restano due possibilità.
- Gli avvenimenti possono essere spiegati come allucinazioni o inganni all’interno di un mondo che risponde, almeno apparentemente, a leggi naturali e razionali, e allora si passa nel campo dello “strano”: di fronte a questi avvenimenti i personaggi appaiono turbati e inquieti per l’improvvisa distorsione della loro realtà abituale. A questa categoria di fantastico appartengono testi come il romanzo Frankenstein (1818), di Mary Shelley (1797-1851), in cui il sogno di uno scienziato di generare la vita da materia inanimata si trasforma in un incubo quando l’uomo perde il controllo della propria creatura. Il dottor Frankenstein dà vita ad una creatura sfruttando le proprie competenze scientifiche e filosofiche, rendendo la vicenda strana e inquietante ma ancorata alla realtà e alle sue leggi, in particolare quelle mediche e scientifiche.
- Gli avvenimenti rientrano all’interno di una realtà accettata come soprannaturale, cioè governata da leggi diverse da quelle della realtà a cui siamo abituati, e allora si passa nel campo del “meraviglioso”: di fronte a questi avvenimenti i personaggi, come i lettori e le lettrici, non provano alcuna sorpresa o turbamento. A questa categoria potremmo ascrivere ad esempio la fiaba, nel cui mondo qualsiasi cosa sia fuori dall’ordinario, da ciò che può essere razionalmente compreso, è accettata da tutti, sia dalla voce narrante che dai personaggi; ad esempio la presenza di uno gnomo è normale.
Quali sono le caratteristiche del genere fantastico?
Il cosiddetto genere “fantastico puro” raccoglie i testi in cui elementi incomprensibili o non verisimili fanno irruzione in un contesto apparentemente realistico.
Da questa definizione generale discendono tutte le altre caratteristiche narrative del fantastico, che sono legate proprio a questa posizione ambigua tra realtà e sogno, nella quale a volte si tende più verso il verisimile, altre più verso l’incomprensibile.
- Il tempo e lo spazio possono essere determinati o indeterminati, e di norma sembrano realistici finché non interviene qualche elemento inspiegabile, come nel caso del visconte Medardo che sopravvive diviso a metà; spesso l’elemento irrazionale crea una sensazione di inquietudine e angoscia legate al disorientamento che chi legge condivide con i personaggi.
- I protagonisti e le protagoniste sono di norma umani/e, ma spesso si trovano a scontrarsi con entità incomprensibili, soprannaturali o bizzarre, come il ladro di giorni perduti della novella di Buzzati.
- Le vicende narrate possono essere eccezionali, come nel caso della divisione a metà del Visconte di Calvino, reduce dalla guerra contro gli infedeli, ma anche di disarmante quotidianità, come nella vicenda di Gregor Samsa, che nonostante abbia subìto una improvvisa e inspiegabile trasformazione da uomo in scarafaggio deve affrontare le consuete preoccupazioni e le ordinarie responsabilità della vita quotidiana.
- Spesso le storie narrate non hanno un significato in sé, ma rimandano chiaramente a un valore simbolico: in questo caso si parlerà allora di “allegoria”. In questa categoria rientrano miti, fiabe e favole, ma anche opere di genere fantastico come La fattoria degli animali di George Orwell (1903-1950), in cui le bestie di una fattoria organizzano una società nuova ed egualitaria – che però si rivelerà fallimentare –, nella quale l’autore rappresenta l’Unione Sovietica della metà del XIX secolo.
Quali autori si sono distinti in questo genere?
Al XIX secolo risalgono i grandi capostipiti del genere fantastico, come E.T.A. Hoffmann (1776-1822) ed Edgar Allan Poe (1809-1849), e ancora Prosper Mérimée (1803-1870) e Iginio Ugo Tarchetti (1839-1869), le cui opere fondevano elementi fantastici con forti suggestioni horror e oniriche. Questo tipo di narrativa stimolava un forte interesse per il lato oscuro dell’animo umano, e curiosità nei confronti delle cose che del mondo sembravano restare misteriose. D’altra parte, in una società che si stava evolvendo anche grazie a scoperte o invenzioni tecnologiche, nasceva la paura di saperle più o meno governare.
È tuttavia nel Novecento che il genere conosce la sua affermazione. A questa contribuì il clima culturale delle avanguardie artistiche, che cercavano espressioni al di fuori di vincoli imposti dalla realtà. Ma fu soprattutto la diffusione della psicologia e della psicanalisi a offrire alla letteratura nuove interpretazioni della realtà. Queste, infatti, attraverso l’indagine dell’inconscio dell’essere umano, permettevano alle sue sfere irrazionali di emergere finalmente con prepotenza.
Henry James (1843-1916), Franz Kafka (1883-1924), Dino Buzzati (1906-1972), Julio Cortázar (1914-1984) e Michael Ende (1929-1995) sono tra i massimi esponenti del genere; così come Italo Calvino (1923-1985), la cui vena fantastica ha attraversato generi e forme assai distanti tra loro.
Italo Calvino, maestro del fantastico
Italo Calvino, nella sua produzione letteraria, ha sperimentato i generi più diversi, dal neorealismo al fantastico più sfrenato. Proviamo allora ad analizzare alcune delle sue opere come modello di diverse tipologie di fantastico.
- Il sentiero dei nidi di ragno (1947) si presenta come un romanzo realistico, il cui protagonista è un bambino partigiano, Pin. Eppure l’atmosfera è fiabesca, e il luogo nel quale fanno il nido i ragni è un luogo dal forte valore simbolico, che rappresenta per Pin un rifugio sicuro dalla violenza della vita che è costretto a vivere.
- Marcovaldo (1952-62) è un insieme di racconti ambientati in una grande città non definita, nella quale il protagonista affronta, da ingenuo campagnolo, una serie di peripezie ai limiti della realtà, che talvolta vanno ben oltre: basti pensare all’episodio in cui, con un semplice starnuto, spazza via la neve da tutto il cortile della sua ditta.
- La trilogia I nostri antenati, che contiene i romanzi Il visconte dimezzato (1952), Il barone rampante (1957) e Il cavaliere inesistente (1959), va letta in chiave allegorica: i protagonisti sono un cavaliere inesistente (cioè un’armatura vuota che cammina, pensa e parla!), un visconte dimezzato (cioè diviso per il lungo da un colpo di cannone in due metà autonome, e alla fine ricucito per tornare un unico uomo) e un barone rampante, che per tutta la sua vita non scenderà mai dagli alberi, muovendosi però in un contesto geograficamente e cronologicamente ben definito come la Liguria di epoca napoleonica.
- Le Cosmicomiche (1963-64), invece, sono dodici brevi racconti di genere fantascientifico il cui protagonista è Qfwfq, del quale «non è nemmeno detto che sia un uomo» e «si deve calcolare che ha più o meno l’età dell’universo».
- Le città invisibili (1972) descrive, infine, 55 città fantastiche, che rispondono a regole diverse da quelle reali, tanto da essere, come dice il titolo, invisibili ai più: ma non al visionario Marco Polo, che le descrive al suo imperatore Kublai Kan.
Nonostante il piacere della narrazione fantastica, Calvino non è uno scrittore di evasione, anzi afferma la necessità che la lettura proponga temi importanti, anche se in forma che lui definisce «leggera». Ciò dimostra quanto il fantastico non serva solo a intrattenere, a distrarre e a divertire, ma sia spesso portatore di temi profondi ed educativi e strumento di indagine sociale e psicologica.
➲ Metti bene a fuoco i concetti fondamentali del genere con il video Il fantastico in 4 passi, poi mettiti alla prova con il test interattivo.
Durata dell'attività: 10 minuti
Per l'insegnante: è possibile modificare il Modulo e condividerlo nelle proprie Classroom. Clicca qui per prelevare il Modulo e copiarlo nel tuo Drive >>