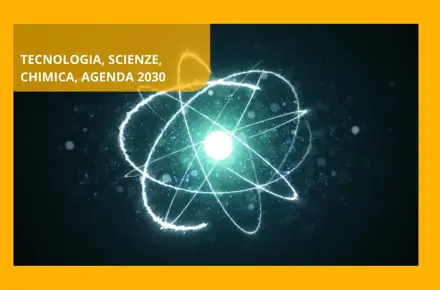Il Manierismo. La lezione digitale
Tra la scomparsa di Raffaello (1520), che segna simbolicamente la fine della grande stagione rinascimentale, e la fine del secolo, si svolge in Italia una fase artistica caratterizzata dal graduale distacco dalle “regole” della “maniera moderna”. Personalità artistiche come Rosso Fiorentino e Pontormo, Giulio Romano e Parmigianino, Bronzino, Benvenuto Cellini e Giambologna rappresentano la nuova stagione.

Il termine “Manierismo” fu coniato alla fine del Settecento per indicare, in tono spregiativo, l’opera di quanti avrebbero assunto a modello non già la natura, come presso gli antichi e i maestri “moderni”, ma l’opera dei maestri stessi, decadendo dunque al rango di semplici imitatori. Oggi il termine viene utilizzato in una diversa accezione, per indicare le esperienze artistiche caratterizzate dal graduale abbandono delle “regole” dei maestri in direzione di nuove sperimentazioni, con esiti antinaturalistici nella rappresentazione degli spazi e delle figure e nell’uso dei colori.
Tra le varie stanze affrescate di Palazzo Te, ciascuna con un tema e uno stile propri ma accomunate dall’intento illusionistico e teatrale, vi è quella intitolata ad Amore e Psiche in cui sono raffigurati amori umani e divini.
Come scultore, Bartolomeo Ammannati seguì la lezione di Michelangelo Buonarroti collaborando all’arredo urbano di Piazza della Signoria. Tra il 1563 e il 1575 eseguì la Fontana del Nettuno, dove il plasticismo della divinità marina fa da contraltare alla stilizzata eleganza delle figure bronzee che circondano la vasca.
Tra le “Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori” a cui si dedicò Giorgio Vasari, da Cimabue a Vasari stesso, non ha l’onore di comparire quella di Benvenuto Cellini. Nella seconda edizione delle Vite (1568) il Vasari gli dedica poche anche se lusinghiere righe all’interno di una rassegna di artisti viventi, giustificando la scelta con il fatto che Cellini aveva già provveduto a scrivere da sé la propria vita: “non ne dirò qui altro, atteso che egli stesso ha scritto la vita e l’opere sue”. In effetti, quando Vasari scrive queste parole, Cellini aveva già dettato una corposa autobiografia dal tono chiaramente apologetico.
Nelle pagine della Vita di Benvenuto di Maestro Giovanni Cellini fiorentino, scritta, per lui medesimo, in Firenze, tra il 1558 e il 1566, l’artista racconta con dovizia di particolari tutta la vicenda collegata alla realizzazione del Perseo, dai difficili rapporti con il Duca committente alle problematiche tecniche.
- Basandoti sul testo della Vita (scaricabile nell’edizione Einaudi dal sito www.letteraturaitaliana.net) e con l’aiuto dell’insegnante di lettere, ricostruisci la vicenda del Perseo ed esponila in un breve saggio destinato alla scuola.