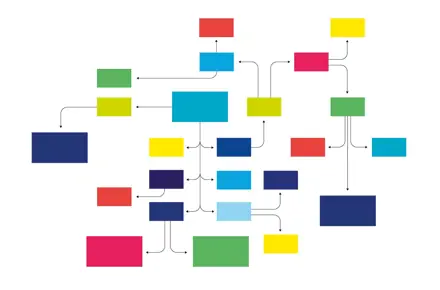Approfondisci la narrativa comica
Personaggi stravaganti, situazioni assurde, imprevisti, equivoci, giochi di parole: sono solo alcuni degli strumenti di cui si serve la narrativa comica per far ridere e divertire chi legge. Ma cosa c'è alla base di una risata? E quanto può farci riflettere ciò di cui sorridiamo?
Che cos’è il comico?
Il comico è una tipologia letteraria che ha uno scopo preciso: farci ridere e divertire, ovvero soddisfare un’esigenza naturale dell’essere umano, nell’antica Grecia come ai giorni nostri. A questo vengono subordinate tutte le altre caratteristiche: la verosimiglianza o l’irrealtà, l’intento educativo e morale o la semplice volontà di intrattenere, uno stile sottile e ironico o una raffica di battute a effetto.
Come nasce il genere comico? E come si è evoluto nel corso del tempo?
La commedia classica
Alla base dell’idea di comico c’è la commedia greca classica, legata al teatro del V secolo a.C.: in essa venivano presentate situazioni paradossali o assurde riconducibili alla vita di tutti i giorni, con l’intento di criticare i difetti della società e stigmatizzare i comportamenti sbagliati. Ridere, in questi casi, era una forma di liberazione, perché permetteva di osservare con distacco tali difetti, riconoscendoli come “altri da sé”; inoltre la commedia aveva una funzione apotropaica, cioè serviva a scongiurare il male e ad allontanare la paura. La commedia greca, quindi, era in realtà una narrazione che trattava temi seri e dagli importanti riflessi sociali, affrontandoli però attraverso il paradosso, l’assurdo o il ridicolo.
Dal Medioevo all'età moderna
Dopo le commedie di età classica, con i greci Aristofane e Menandro e i romani Plauto e Terenzio, durante il Medioevo il comico caratterizza diverse novelle del Decamerone (1351) di Giovanni Boccaccio (1313-1375) – nelle quali l’intraprendenza e la scaltrezza dei personaggi si esprime anche attraverso fulminanti battute di spirito, capaci di risolvere situazioni critiche, come in Chichibio e la gru o ne La racchia impenitente– ed episodi dei Racconti di Canterbury (1388) dell’inglese Geoffrey Chaucer (1343-1400). In età moderna spicca il francese Francois Rabelais (1494-1553) con Gargantua e Pantagruel, romanzo composto da cinque libri pubblicati tra il 1532 e il 1564, in cui si narrano le avventure di due principi, un padre e un figlio, di dimensioni giganti, attraverso situazioni grottesche e paradossali. Lo spagnolo Miguel de Cervantes (1547-1616), autore di Don Chisciotte della Mancia (1605), racconta invece le improbabili avventure del cavaliere don Chisciotte e del suo aiutante Sancho Panza attraverso la parodia del genere cavalleresco.
Il comico nell'Ottocento
La “vena comica” è trasversale non solo ai diversi generi letterari, ma anche ai grandi autori: il russo Anton Čechov (1860-1904) esordì sotto falso nome scrivendo racconti umoristici, raccolti in Favole di Melpomene (1884) e Racconti variopinti (1886); anche il primo romanzo pubblicato dall’inglese Charles Dickens (1812-1870), Il circolo Pickwick (1836-1837), fu scritto con il deliberato intento di intrattenere il pubblico con leggerezza.
Negli Stati Uniti Mark Twain (1835-1910) si cimentò con diversi racconti umoristici, tra cui spicca Il diario di Adamo ed Eva (1904-1905), rilettura ironica di un tema biblico. Tre uomini in barca (1889) e Tre uomini a zonzo (1900) sono tra le opere più celebri di Jerome K. Jerome (1859-1927), considerate classici del genere.
Dal Novecento ad oggi
Nel primo Novecento in Italia si distinsero Achille Campanile (1899-1977), autore di opere teatrali e di racconti, tra cui spiccano quelli della raccolta del 1973 Manuale di conversazione, e Giovannino Guareschi (1908-1968), che nelle vicende di don Camillo e Peppone coniugò comicità e critica sociale e politica. Esordisce alla fine degli anni Settanta Stefano Benni (1947), prolifico autore di romanzi, racconti e opere teatrali.
Il francese Daniel Pennac (1944) e lo statunitense David Sedaris (1956), infine, sono tra gli autori che hanno riscosso maggior successo negli ultimi anni, pur proponendo tipi di comicità differente: poetica e sognante il primo, crudamente autobiografica il secondo.
Qual è la differenza tra comico e umoristico?
Nel 1908 Luigi Pirandello (1867-1936) pubblica il saggio L’umorismo, in cui opera una fondamentale distinzione tra comico e umoristico: lo scrittore e drammaturgo siciliano opponeva all’«avvertimento del contrario», alla base del comico, il «sentimento del contrario», tipico invece dell’umorismo.
Se il primo genera una risata immediata, che si arresta all’impressione comica di ciò che osserviamo, il secondo genera invece una riflessione da cui deriva una risata dal sapore più amaro.
Dietro una risata ci può essere, dunque, la semplice volontà di intrattenere, spesso in modo intelligente, arguto e comunque spensierato, ma anche un obiettivo più profondo: spingerci a riflettere.
In questo caso, la comicità diventa umorismo: si ride ancora, ma in maniera diversa, all’interno di una cornice in cui possiamo riconoscere temi, problemi e contraddizioni che ci portano a vedere oltre la risata, a indagare sotto la sua superficie. Si ride – o piuttosto si sorride – perché ci viene presentata in modo leggero e divertente una situazione che riconosciamo come sbagliata. Il romanzo o il racconto che stiamo leggendo ci spingono a riflettere su vizi ed errori degli altri e di noi stessi/e, su ciò che ci preoccupa o ci affligge.
La comicità fa sempre ridere?
Non tutte le opere comiche resistono alla prova del tempo: una parte della letteratura comica del passato, che senza dubbio il pubblico contemporaneo trovava divertente, oggi è per noi quasi incomprensibile. La ragione è che la sua comicità è legata ad abitudini, usanze e stili di vita tipici di un’epoca trascorsa, che non trovano eco nella sensibilità di lettori e lettrici di epoche successive.
In altri casi, invece, la comicità si fonda su aspetti della natura umana universali, trasversali a luoghi ed epoche. È il caso di Mark Twain (1835-1910), uno dei più grandi scrittori statunitensi, autore di numerosi racconti brevi che, più che comici, vanno considerati umoristici: questi infatti propongono riflessioni su temi legati alla natura umana, e che per questo non perdono di attualità. Per esempio, nel racconto breve Come diressi un giornale di agricoltori, un caporedattore rimprovera un suo giornalista di non essere preparato sui temi agricoli che deve trattare, e di inventarsi le notizie di sana pianta. L’altro, un po’ offeso, gli dà una risposta che fa ridere e riflettere allo stesso tempo, e che è applicabile ad ambiti ed epoche diversi e lontani da quelli originari:
«Zucca vuota, testa di rapa, figlio di un broccolo, ma come? È la prima volta che sento tanta ottusità. Sono nel giornalismo da quattordici anni, ecco cosa le dico, e questa è la prima volta che mi s’informa che bisogna saper qualcosa per scrivere su un giornale».
Quali sono le caratteristiche della narrativa comica?
Ciò che rende un testo divertente non è solo il contenuto, quanto il modo in cui questo contenuto e presentato. Nel racconto e nel romanzo comico, quindi, l’ambientazione geografica e storica, il tipo di personaggi, l’intreccio possono essere variabili e sovrapporsi a quelli tipici di altri generi letterari: la fantascienza, come nel caso della Guida galattica per autostoppisti (1979) di Douglas Adams, che racconta le rocambolesche avventure di un essere umano in fuga dal pianeta Terra; il giallo, come nella serie dei romanzi del BarLume di Marco Malvaldi (1974); fino a saggi storicamente rigorosi ma molto divertenti, come Declino e caduta di praticamente tutti (2013) di Will Cuppy, in cui si passano in rassegna in chiave satirica i più grandi personaggi dell’umanità.
Quali sono dunque le tecniche per ottenere l’effetto comico?
- I personaggi, o almeno alcuni o alcune di essi, devono essere stravaganti, possedere caratteristiche particolari e non in linea con il contesto nel quale si muovono: possono avere manie specifiche, oppure tratti fisici bizzarri (come Gargantua e Pantagruel), o ancora semplicemente avere una percezione della realtà che risulta assurda e fuori posto (come don Chisciotte). Spesso l’effetto comico è raggiunto attraverso la caricatura, ovvero l’esagerazione dei tratti caratteristici di un personaggio, che porta a ingigantirne difetti e manie; anche evidenziare il contrasto tra le ambizioni di un personaggio e le sue modeste conquiste è una tecnica tipica del genere.
- La struttura narrativa è di solito complessa e intricata, con un ritmo veloce e frequenti colpi di scena, situazioni assurde, imprevisti, esagerazioni ed equivoci; spesso viene sfruttato il meccanismo della ripetizione, che porta a riproporre più volte una stessa situazione, capace di generare in momenti e contesti diversi le medesime dinamiche comiche. Soprattutto nella narrazione breve, inoltre, l’effetto comico si può ottenere attraverso il finale a sorpresa, cioè con una conclusione del tutto opposta a quella che chi legge si sarebbe aspettato.
- Lo stile e le tecniche espressive sono fondamentali per ottenere l’effetto comico: il linguaggio è sempre molto espressivo, con giochi di parole, uso del nonsense, allusioni, paradossi e spesso un registro stilistico colloquiale o gergale, ma anche inaspettati salti di registro linguistico, che creano divertenti “stonature” lessicali. Tra le tecniche più utilizzate nel genere comico c’è l’ironia, che si fonda sull’esprimere un pensiero, un’opinione o un giudizio dicendo l’esatto contrario, sfruttando così l’evidente contrasto tra intenzione ed espressione (ad esempio, dicendo “è proprio gustoso!” di un piatto insipido e senza sapore); l’ironia può essere palese ed evidente o sottile e più nascosta.
- Le sfumature con cui si può rendere il comico sono diverse, tanto da aver dato vita ad alcuni sottogeneri specifici: la satira si prende gioco di personaggi e situazioni con piglio critico e pungente, e spesso è uno strumento di denuncia sociale e politica; la parodia “fa il verso” a personaggi, situazioni e generi letterari, ne propone un’imitazione dissacrante che fa emergere il loro lato ridicolo.
➲ Metti bene a fuoco i concetti fondamentali del genere con il video Il genere comico e umoristico in 4 passi, poi mettiti alla prova con il test interattivo.
Durata dell'attività: 10 minuti
Per l'insegnante: è possibile modificare il Modulo e condividerlo nelle proprie Classroom. Clicca qui per prelevare il Modulo e copiarlo nel tuo Drive >>